|
| 
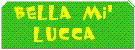
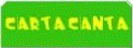




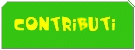






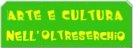
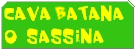

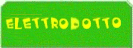
|
Per non dimenticare le vittime degli eccidi nazisti nell'estate 1944
Domenica 5 novembre 2006,
dopo la Santa Messa delle ore 11
alla presenza delle autorità cittadine
presso la chiesa di S. Maria a Colle
(della Provincia e del Comune di Lucca, che hanno patrocinato l'iniziativa),
è stata scoperta, nello spazio attiguo all'ingresso del cimitero,
una lapide per ricordare le vittime
degli efferati eccidi compiuti in
paese dalle truppe di occupazione
naziste nell'estate del 1944.
|
UNA LAPIDE PER NON DIMENTICARE
Autore di questi crimini (furono assassinati a sangue freddo giovani inermi) un sergente delle S.S., certo Papuska. Il 18 agosto il Papuska prelevò dalla sua abitazione, situata in Santa Maria a Colle, un giovane, Giannini Raffaello, lo condusse a Nozzano San Pietro e ivi lo uccise in Corte "Cosci".
Il 23 agosto, il medesimo, assieme al suo interprete, soprannominato "Il Bolzanino", piombò all'improvviso nella corte "Al Tenente", dove massacrò a sangue freddo i cugini Vannucci Alberto e Vannucci Cherubino. Quindi ordinò ai genitori di Alberto di seppellire i due corpi in un campo di patate: in caso di rifiuto avrebbe sterminato l'intera famiglia. Successivamente, con l'aiuto del "Bolzanino", rastrellò nella stessa corte e in quella adiacente, altri tre giovani: Vannucci Pompilio, Vannucci Aurelio (fratelli di Alberto) e Vannucci Pietro. I tre sventurati furono avviati verso il comando tedesco di Nozzano, ma, lungo la strada, in seguito ad un tentativo di fuga, furono trucidati a colpi di pistola.
Il mattino del giorno 24 il criminale nazista fece irruzione nella corte "Al Treppia" dove assassinò, nei pressi della sua abitazione, Palagi Alessandro.
Gli episodi di cui sopra sono stati riferiti con dovizia di particolari non soltanto dai testimoni tutt'ora viventi, ma anche dal parroco di allora Don Pio Serafini, in un diario (De Tempore belli) depositato presso l'Istituto Storico della Resistenza; nonché dal dott. Pilade Osvaldo Nardi in un recente libro di memorie, Ricordi del giorno dopo. Inoltre, relativamente a questi fatti, esistono le testimonianze scritte, rilasciate da don Serafini e dal dott. Nardi ai carabinieri di Nozzano nel dicembre 1948. Entrambi, mossi da spirito di abnegazione e carità cristiana, adoprandosi in ogni modo per alleviare le sofferenze della popolazione e offrire il loro aiuto in una situazione tanto difficile, furono drammaticamente coinvolti in questi fatti a gravissimo rischio della vita. Il Papuska, infatti, fu più volte sul punto di assassinarli e soltanto circostanze fortuite, talvolta rocambolesche, determinarono la loro salvezza.
Si è deciso di collocare la lapide nel suddetto luogo, perché proprio lì don Pio, contravvenendo al divieto del Papuska, fece confluire alcune delle salme per benedirle e successivamente inumarle nel cimitero dove tutt'oggi riposano; e perché proprio lì, mentre si apprestava ad assolvere quel pietoso ufficio, il sergente SS fu sul punto di uccidere anche lui (stava per sparargli, quando un cavallo, improvvisamente imbizzarrito, distrasse il criminale e consentì al sacerdote di rifugiarsi in chiesa).
Sulla lapide si è ritenuto doveroso aggiungere, ai nomi delle sette vittime sopra indicate, quelli di altri cinque giovani del paese che persero ugualmente la vita per mano nazista: Maffei Giuseppe, Bertolucci Carlo, Bertolucci Giuseppe (civili periti nella strage della Certosa di Farneta); Lena Nello (deportato in Germania e disperso); Bianchini Renzo, un partigiano che si battè eroicamente nella difesa di Forno di Massa il 13 giugno 1944, quando soverchianti forze nemiche (S.S. tedesche, reparti fascisti della X Mas e della Guardia nazionale repubblicana) attaccarono le postazioni partigiane. Il Bianchini, pur gravemente ferito, rimase a sparare con il suo bren fino all'esaurimento delle munizioni. Caduto infine prigioniero, fu rinchiuso con quattordici compagni nella caserma dei carabinieri di Forno e lasciato morire tra le fiamme.
05.11.2006, S.Maria a Colle

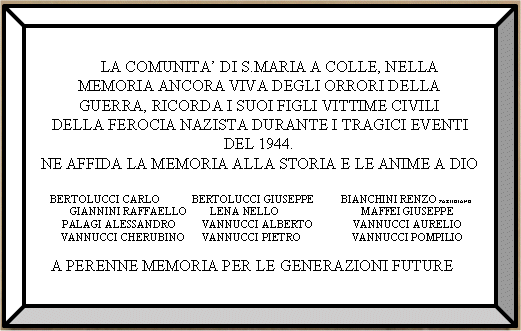
Intervento di WALTER RAMACCIOTTI fatto il 5 novembre '06 a S. Maria a Colle in occasione dell'inaugurazione e della benedizione di una lapide di commemorazione delle vittime civili della ferocia nazista durante la seconda guerra mondiale.
Sessantadue anni fa e precisamente nel mese di agosto 1944 don Pio Serafini, parroco di S. Maria a Colle, ebbe l'idea di trasformare la sala del piccolo cinema parrocchiale in ospedale per raccogliere gli ammalati di tutta la zona. Per la richiesta alle autorità si avvalse della collaborazione del Geom. Raffaele Fambrini, persona stimata e di un cero prestigio, così racconta nel suo libro il dott. Pilade Nardi. Ai primi del mese di agosto del 1944, don Pio e il dott. Nardi furono ricevuti dal comandante militare e prefetto Hidreno Utimperg al palazzo della Prefettura ed ottennero l'atto di autorizzazione dell'apertura dell'ospedale e un atto di requisizione di due vacche per l'alimentazione dei malati. Nel consegnare il documento agli interessati, il Prefetto non nascose loro che i tempi si sarebbero fatti sempre più difficili, particolarmente al ritiro delle ultime truppe, cosa che purtroppo avvenne: basti pensare alla tragedia della Certosa di Farneta nei primi giorni di settembre dello stesso anno. Prima di congedare gli interessati il Prefetto Utimperg consegnò loro una busta contenente settemila lire per fare le provviste per l'ospedale e per la popolazione ed augurò loro buona fortuna. Usciti dalla Prefettura, don Pio e il dott. Nardi (a quest'ultimo fu affidata la parte sanitaria) si recarono all'ospedale militare di Via Galli Tassi, mostrarono l'autorizzazione e chiesero aiuto, ottenendo ben poco. Tornati a S. Maria a Colle, gli undici letti allestiti nella sala parrocchiale erano già in parte occupati da ammalati di forme croniche, residenti in zone difficili e di pericoloso acceso al medico. Don Pio, per ragioni di sicurezza, fece dipingere un grande stemma della Croce Rossa sul tetto del piccolo ospedale e disse che era opportuno allestire anche un rifugio dove ricoverarsi in considerazione che con l'avanzata delle truppe alleate potevano esserci bombardamenti e cannoneggiamenti.
Tante furono le difficoltà personali e materiali che don Pio Serafini e il dott. Nardi dovettero fronteggiare, ma nonostante ciò riuscirono a farvi fronte ed a salvare la vita ad alcune persone. Nel frattempo erano cominciati i rastrellamenti e la deportazione degli uomini e i soldati delle SS erano subentrati a quelli della Wermach ed i permessi rilasciati da quest'ultimi non erano più validi.
Un aiuto provvidenziale per il piccolo ospedale di S. Maria a Colle venne dalla chiusura della farmacia di Ponte S. Pietro: la titolare era anziana e sfollò in zona più tranquilla. Prima di partire questa signora consegnò a don Pio per l'ospedale molti medicinali da banco e da medicazione. Ma i problemi per il dott. Nardi, i cui ricordi saranno pubblicati in un volume di ricordi di guerra e di pace che uscirà nel prossimo anno, non erano ancora terminati: negli ultimi giorni dell'occupazione un soldato tedesco aprì la porta della stalla di Lello e portò via la vacca, unico bene di sostentamento rimasto per i degenti dell'ospedale. Il dott. Nardi, saputa la notizia dal ritorno da una visita, salì di nuovo in bicicletta, inseguì il soldato e lo raggiunse all'altezza del paese di Nave. Gli si mise davanti con la bicicletta impedendogli di avanzare e gli fece vedere il permesso che attestava la funzione di direttore dell'ospedale e fece presente che la bestia non poteva essere requisita. Tra il soldato tedesco e il dott. Nardi ci fu quasi una colluttazione, ma quest'ultimo dopo aver afferrato la fune con la quale era legata la vacca, alla fine riuscì a far lasciare la presa al soldato e a ricondurre la bestia a S. Maria a Colle.
Nessuno di coloro che assistettero al fatto si mosse in soccorso del dott. Nardi, il quale una volto rientrato in paese riconsegnò la vacca a Lello con grande sorpresa di quest'ultimo e l'unico mezzo di sostentamento per i degenti di questo piccolo ospedale non venne meno grazie al coraggio del dott. Nardi che insieme al Parroco di S. Maria a Colle, con i modesti mezzi a loro disposizione, riuscirono ad aiutare la popolazione e a salvare da sicura morte alcune persone.
Ricordare l'opera di queste persone che incuranti della propria incolumità hanno aiutato coloro che maggiormente avevano bisogno durante la guerra e farle conoscere alle nuove generazioni, in particolare ai giovani, è un dovere da parte della collettività ed un giusto riconoscimento morale.
(Walter Ramacciotti)
|







